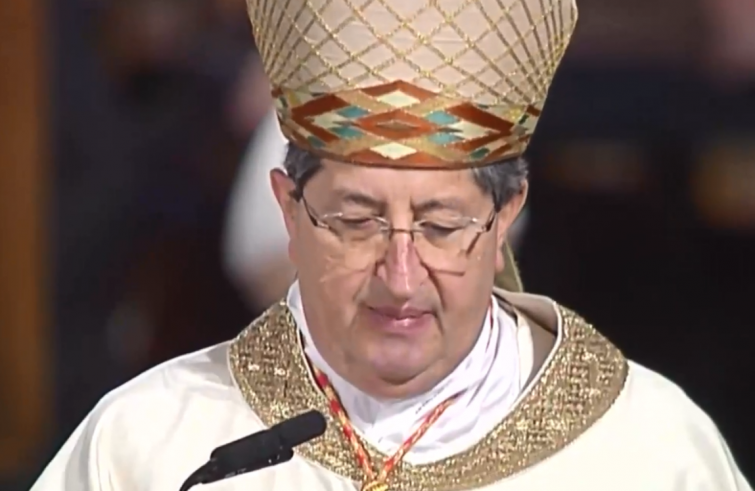La pandemia ci priva del gesto della lavanda dei piedi, ma la celebrazione nella “Cena del Signore” non perde per questo il suo carattere di rappresentazione di come Gesù che si è fatto nostro servo e di chiamata a noi, suoi discepoli, a farci servi gli uni degli altri. Perché proprio questo è il senso dell’Eucaristia, della cui istituzione stasera si fa memoria. Per questo motivo l’evangelista Giovanni non teme di omettere parole e geti che Gesù compie istituendo l’Eucaristia, come fanno gli altri vangeli, in quanto la lavanda dei piedi ne illumina il significato: lo stesso mistero d’amore è espresso nel gesto simbolico della lavanda e manifestato nel gesto reale del pane fatto Carne e del vino fatto Sangue di Gesù. Ambedue i gesti sono affidati dal Signore ai suoi, come compito da ripetere nei secoli: «Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15) e «Fate questo in memoria di me» (Gv 11,24). Il servizio e il sacramento costituiscono un unico comando, che ci conforma a Gesù.
Come riuscire a entrare in questo mistero, noi fragili peccatori? Non certamente per nostra capacità, ma solo per grazia. La grazia che ci giunge come liberazione dal male in forza del sacrificio di Gesù. La liturgia lo indica aprendo le letture della parola di Dio con la pagina del libro dell’Esodo che narra la notte della Pasqua in Egitto, la notte della liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù. A liberare in quella notte le case degli israeliti dalla morte che scende sulle case d’Egitto è il sangue dell’agnello, immolato in sacrificio e cibo da condividere, con il cuore pronto ad affrontare il cammino dell’Esodo: «È la Pasqua del Signore!» (Es 12,11). È Pasqua, cioè il Signore “passa oltre” le case degli israeliti che vengono risparmiate dalla morte e da esse il popolo, dopo aver condiviso la mensa, esce verso la libertà.
Questa libertà, offerta per atto di misericordia divina e raggiunta attraverso un lungo cammino nel deserto, è solo il segno di un’altra libertà che ci viene offerta in forza del sangue di un altro sacrificio, quello di Gesù sulla croce, che apre a noi il cammino verso la vittoria sul peccato e sulla morte, in forza di un legame con lui e con il Padre, un’alleanza, che ci apre le porte alla partecipazione alla vita stessa di Dio. Un’alleanza che si compie nella condivisione della mensa del suo corpo e del suo sangue, il cibo della vita, «lo pan che ’l pio Padre a nessun serra», come dice Dante (Paradiso XVIII, 129), «cotidiana manna / senza la qual per questo aspro deserto / a retro va chi più di gir s’affanna» (Purgatorio XI, 13-15). Solo trasformati dal cibo che è Cristo per noi, potremo affrancarci dal peso del male per conformarci a lui.
Questo mistero di liberazione e santificazione nel sacrificio di Cristo è quanto egli stesso ci propone di condividere partecipando alla cena in cui il suo Corpo e il suo Sangue ci vengono comunicati perché siano principio di trasformazione della nostra esistenza. Ci è chiesto di mangiare e bere il pane e il vino divenuti Corpo e Sangue di Cristo per fare memoria di lui, come ci ha narrato l’apostolo Paolo. E la memoria è sì del rito, ma solo in quanto esso implica un’adesione a ciò che il mistero di quel Corpo e Sangue significano: una vita donata, un farsi schiavo degli uomini da parte del Figlio di Dio, che ora ci chiede di farci schiavi gli uni degli altri riconoscendo negli altri il suo stesso volto.
Una vita donata è quanto Gesù ci mostra e ci chiede. E in questa espressione l’aggettivo vale più del sostantivo. Perché non basta una vita qualsiasi, una vita senza qualità, occorre una vita che si lasci illuminare dal dono di sé. Niente di più falso del detto popolare: «Basta la salute». Non basta, anzitutto perché accade che a un certo punto della vita la salute non basti più e giunga la morte, come l’attuale pandemia ci costringe a riconoscere. Ma non basta la salute, soprattutto perché da sola non è sufficiente a riempire di senso una vita, come mostrano le insofferenze alle attuali restrizioni, soprattutto i timori per come potrà essere il futuro, i segni crescenti di depressioni e di aggressività, anche tra i più giovani. Non basta la salute, non basta la vita, occorre dare un senso pieno ai nostri giorni. Un senso che non può venire dalla presunzione di dominare tutto, di avere tutto, di essere svincolati da tutti. Proprio la crisi pandemica ci ha mostrato come sia illusoria questa arroganza dell’uomo moderno che, distaccatosi da Dio, non ha trovato altro terreno saldo su cui edificare la propria esistenza. Questa si illumina solo quando abbiamo il coraggio di viverla come Gesù, nel dono di sé al Padre e ai fratelli, un unico progetto di vita, che nella parola di Dio trova i suoi criteri di verità e nella relazione con gli altri incontra il terreno su cui mostrarla.
Anche in questo la pandemia ci è maestra, in quanto è difficile contestare che il volto bello dell’umanità si è rivelato nelle scelte e nei comportamenti solidali con cui, per responsabilità professionale o civica ovvero per scelta di volontariato, ci si è presi cura gli uni degli altri, perché nessuno restasse ai margini, fosse dimenticato. Non dovrà essere questo il carattere del mondo futuro, se vogliamo davvero salvarci dalla tempesta?
L’avidità, i nazionalismi, il profitto, le leggi di un mercato che ha al suo centro il denaro e non la persona umana, l’individualismo e l’egoismo vanno nella direzione opposta e sono l’esatto contrario di quanto stiamo meditando stasera e di quel sogno di un mondo di fratelli che il Papa indica all’umanità come sua sola prospettiva di salvezza. Ascoltiamo le sue parole: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!» (Fratelli tutti, 8). Accogliamo queste parole come un programma di vita personale e un progetto di convivenza sociale.